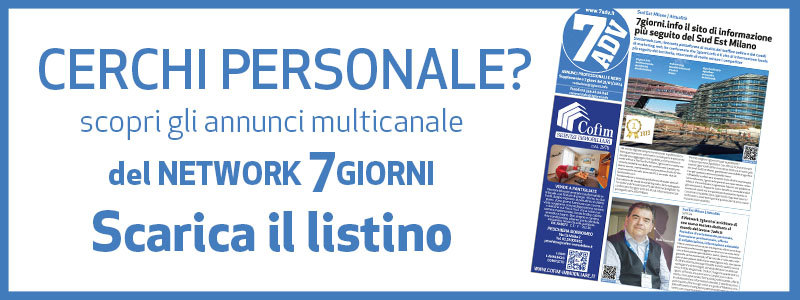«Non siamo con Putin ma non vogliamo la guerra», l’ossimoro che ignora la realtà del conflitto: quando la neutralità diventa complicità
Chi si oppone alla guerra senza riconoscere l’aggressore finisce per legittimare l’oppressore. L’«equidistanza» tra aggredito e aggressore è la negazione della responsabilità morale.

«Finché non tocca a me, non mi riguarda»
Nel dibattito pubblico italiano, una delle frasi più ricorrenti e apparentemente pacifiste è: «Non siamo con Putin, ma non vogliamo la guerra». Un’affermazione che, a prima vista, potrebbe sembrare equilibrata, quasi nobile. In realtà, cela una profonda ambiguità, diventando un ossimoro che finisce per negare l’evidenza e, ancor peggio, per trasmettere un implicito messaggio di indifferenza verso la tragedia dell’Ucraina.
Un’aggressione evidente
Nel febbraio 2022, la Federazione Russa ha invaso un Paese sovrano: l’Ucraina. Ha violato confini riconosciuti dal diritto internazionale, ha bombardato città, ucciso civili, deportato bambini, distrutto infrastrutture. Questa non è una guerra tra due parti uguali: è l’aggressione brutale di uno Stato autoritario contro una democrazia imperfetta, ma libera. Vladimir Putin, al potere da oltre vent’anni, è l’unico responsabile di questo conflitto.
Il paradosso pacifista
Dire «non siamo con Putin ma non vogliamo la guerra» diventa allora un paradosso. Se è Putin a volere la guerra, se è lui ad averla iniziata e a mantenerla viva con minacce, repressione e propaganda, allora come si può essere davvero contro di lui senza accettare la necessità di opporvisi? Chi difende l’Ucraina non lo fa per amore delle armi, ma per senso di giustizia, per il rispetto del diritto internazionale e della libertà dei popoli.
Il sottotesto dell’indifferenza
A ben vedere, quell’affermazione nasconde un’altra, più cinica: «Finché non tocca a me, non mi riguarda». È una forma moderna e politicamente corretta di menefreghismo. Come se le vittime ucraine fossero meno importanti della nostra tranquillità. Come se la libertà, il diritto a non essere invasi, a non essere bombardati, fossero privilegi negoziabili in nome della pace apparente.
Ripudio della guerra, ma con giustizia
La Costituzione italiana, all’articolo 11, afferma che l’Italia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli». Non dice che la ripudia sempre e comunque: la guerra di aggressione è ripudiata, non la difesa contro di essa. Anzi, proprio per coerenza con i valori costituzionali, l’Italia dovrebbe sostenere chi è stato invaso, chi sta difendendo la propria libertà, la propria sovranità, la propria esistenza.
Neutralità che diventa complicità
La storia insegna che la neutralità davanti all’ingiustizia è una forma di complicità. Non prendere posizione quando un popolo viene aggredito non è pacifismo, è passività. E la passività, davanti ai crimini, non è una virtù: è un modo per lasciarli accadere. L’«equidistanza» tra aggredito e aggressore è la negazione della responsabilità morale.
Non si può dire di non essere con Putin e, allo stesso tempo, rifiutare ogni forma di reazione all’invasione russa. La pace non è solo assenza di guerra, ma anche giustizia e libertà. Difendere l’Ucraina non significa voler la guerra, ma scegliere di non lasciare soli i popoli che lottano per la propria autodeterminazione. È ora di smascherare il comodo ossimoro e ammettere che, in certi momenti storici, la neutralità non è altro che una forma di resa morale.
Giulio Carnevale
 Newsletter
Newsletter  Pubblicità
Pubblicità  Redazione
Redazione