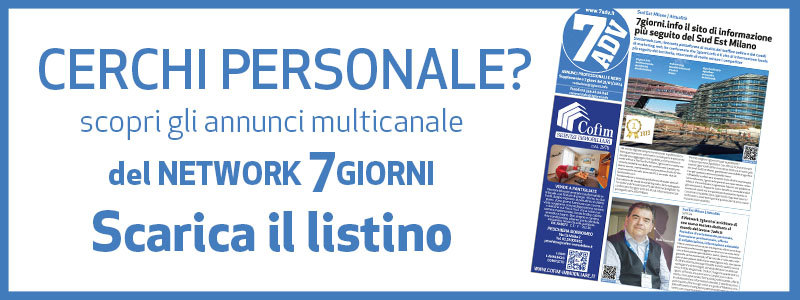In occasione delle celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, la scrittrice Petra Di Laghi nel suo tour fara tappa a San Giuliano Milanese, a Mediglia e al Municipo IV di Milano. Il programma completo degli eventi del Comitato 10 Febbraio.
Al termine della Seconda guerra mondiale comincia l’esodo di
circa trecentomila italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, terre di
confine sottoposte per decenni a catastrofi belliche, stravolgimenti di regimi
e nazionalità, capovolgimenti culturali e linguistici. Il libro ricostruisce
non solo le vicende che provocarono quello spostamento di massa dopo la tragica
stagione delle foibe e il passaggio di quei territori sotto il regime
jugoslavo, ma anche il lungo viaggio che i profughi dovettero intraprendere
verso la ricerca della normalità di una fissa dimora. Attraverso testimonianze
e documenti inediti si delinea il difficile percorso degli esuli nell’Italia
del secondo dopoguerra e all’interno dei Centri Raccolta Profughi sparsi in
tutta la penisola. In particolare, il volume analizza il programma
assistenziale che la provincia di Genova attivò dal 1945 fino al raggiungimento
di una residenza stabile nella seconda metà degli anni Cinquanta.
L’opera può
essere indirizzata ad un pubblico non informato sul tema dell’esodo e del
confine orientale grazie alla ricostruzione storica degli eventi e delle
vicende storiche dei territori della Venezia Giulia durante la Seconda guerra
mondiale e del clima in cui la maggioranza della popolazione italiana maturò la
scelta dell’abbandono.
Nodo centrale di
tutta l’opera è il tema dell’accoglienza e dell’assistenza offerta ai profughi
giuliano-dalmati nella società italiana del secondo dopoguerra, argomento
riguardante un periodo particolare della storia italiana. Per poter osservare da vicino tali dinamiche
viene esposta, come importante parte inedita, l'analisi delle iniziative
assistenziali attivate dalla città di Genova nei confronti degli esuli, nel
periodo compreso tra il 1945 e il 1955.
Grazie ai dati
reperiti dalla ricerca svolta presso l’Archivio di Stato di Genova, l’Archivio
storico del Comune di Genova, l’Ufficio territoriale del governo di Genova
(sezione Profughi ed equiparati) e presso la Biblioteca Universitaria di
Genova, il libro si configura dunque anche come utile strumento per
ricercatori e studenti che volessero approfondire l’argomento
dell’accoglienza dei profughi giuliani, con particolare riguardo per la storia
dei Centri Raccolta Profughi della Liguria.
Nell’arco di un
decennio, dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni
Cinquanta la comunità italiana dell’Istria, Fiume e Dalmazia quasi si dissolve.
Le cifre variano dalle 280.000 alle 350.000 persone, più di un quarto di
milione circa. Rispetto ai numeri è però l’aspetto totalizzante di quella dolorosa scelta.
Rispetto
ai diversi fenomeni di spostamento di
popolazione che coinvolsero l'Adriatico, l’esodo giuliano-dalmata si distinse
per le dimensioni nettamente superiori e determinò la scomparsa quasi totale
della minoranza italiana.
L’esodo istriano costituisce una spaccatura molto
evidente con il passato, rispetto agli spostamenti forzati avvenuti in
tutta Europa nel secondo dopoguerra e alle precedenti migrazioni di sloveni e
croati al termine della prima guerra mondiale. Secondo Raul Pupo, il fenomeno
determina: «la scomparsa dalle sponde adriatiche della forma specifica di
presenza italiana che lì si era costituita come ultimo atto di una vicenda
storica iniziata all'epoca della romanizzazione».
Gli italiani d’Istria, Fiume e
Dalmazia abbandonarono le sponde dell’Alto Adriatico per quasi il 90%
disperdendosi nel mondo e in particolare in Italia, dove vennero sistemati nei 109 Centri raccolta
profughi sparsi in tutta la penisola.
Nelle
diverse province italiane, oltre ai campi profughi governativi, si registrarono
anche altre soluzioni assistenziali - spesso molto precarie - quali alberghi,
dormitori, enti pubblici e alloggi collettivi gestiti privatamente.
Un esempio fu la città di Genova, per la natura
frammentaria della disposizione dei diversi rifugi assistenziali e dove
l’unico Centro Raccolta Profughi governativo era situato oltre il perimetro
urbano nella cittadina del Levante Ligure di Chiavari.
Nella sola Liguria coloro che vennero accolti e vi trovarono
residenza stabile furono 8.345, come rivela un censimento effettuato da Amedeo
Colella nel 1958 per conto dell'Opera per l'assistenza ai profughi
giuliano-dalmati e nella realtà genovese ben 6.530 provenienti dall'Istria,
Fiume e Dalmazia.
Programma presentazioni
VENERDI 31 GENNAIO
h.18.00
Milano, Regione Lombardia, Sala del
Gonfalone Palazzo Pirelli
SABATO 1 FEBBRAIO
h.11.00
Milano Zona 4
SABATO 1 FEBBRAIO
h.16.00
Cologno Monzese, Sala Pertini, Villa
Casati, Via Mazzini 9
DOMENICA 2 FEBBRAIO
h.11.00
Mediglia, Biblioteca, Piazza Terracini
Mombretto
DOMENICA 2 FEBBRAIO
h.16.00
San Giuliano Milanese Sala Previato -
Piazza della Vittoria
LUNEDI 3 FEBBRAIO
h.17.00
Milano, Sala Conferenze ANVGD, via Duccio di
Boninsegna 21/23
LUNEDI 3 FEBBRAIO
h.21.00
Sesto San Giovanni, Biblioteca, Villa
Visconti d'Aragona, via Dante 6Petra Di Laghi
(Genova, 1992) è laureata in Scienze storiche a Torino
con la tesi L’esodo giuliano-dalmata tra emergenza e accoglienza: il caso di
Genova (1945-1955). È specializzata in comunicazione storica e ha
approfondito la materia della formazione, gestione e conservazione di archivi
digitali in ambito pubblico e privato. Sul tema dell’esodo istriano e
sull’accoglienza dei profughi giuliani ha pubblicato vari articoli e tenuto
conferenze. Collabora con la libera associazione “Coordinamento Adriatico” ed è
membro del “Comitato 10 Febbraio”. Questo
volume è il frutto degli ulteriori approfondimenti e ampliamenti delle sue
ricerche sull’argomento.
Il
Comitato 10 Febbraio (
www.10febbraio.it), sorto successivamente
alla promulgazione della Legge 92 del 30 marzo 2004 istitutiva del Giorno del
Ricordo, raccoglie soprattutto cittadini italiani che, pur senza avere un
legame diretto o famigliare con le tragedie delle Foibe e dell’Esodo
giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di
storia patria. Presente con i suoi Comitati in molte regioni d’Italia (Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia – Romagna, Toscana, Umbria,
Abruzzo, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), il C10F collabora con
altre associazioni culturali, scuole ed amministrazioni locali interessate a
svolgere momenti di approfondimento sulla storia del confine orientale
italiano. Per non dimenticare è fondamentale che i più giovani studino la
storia con le sue luci e le sue ombre, con le contraddizioni e le vergogne,
perché è proprio agli studenti di oggi che è dato il compito di non dimenticare
mai più e di riattaccare le pagine strappate dal grande libro della storia
nazionale. Tuttavia non sono al centro delle nostre attività solamente le
dinamiche che condussero al massacro di 20.000 connazionali durante la stagione
di terrore delle Foibe ed al successivo Esodo di 350.000 istriani, fiumani e
dalmati, bensì anche la storia complessiva dell’italianità nell’Adriatico
orientale e le prospettive per la salvaguardia dell’identità italiana in quelle
terre. Nostro intento, infatti, è quello di fiancheggiare le associazioni della
diaspora giuliano-dalmata nella sensibilizzazione e nell’informazione
dell’opinione pubblica sulla storia plurisecolare di una regione italiana di
confine, da sempre connessa per lingua, cultura e tradizioni con la penisola
italica. In continuità con questa storia, che parla anche di convivenza con
altri popoli e culture fino alla stagione degli opposti nazionalismi della
seconda metà dell’Ottocento, è nostro intento interfacciarci con le Comunità
degli Italiani ancora presenti in loco, al fine di riallacciare un legame
culturale in nome di una riscoperta identitaria. Si tratta dell’identità
italiana dell’Adriatico orientale, che affonda le sue radici nell’Arena di Pola
e nel Palazzo di Diocleziano a Spalato, fiorisce nei leoni di San Marco che
decorano chiese, fortezze e palazzi nei secoli di dominio della Serenissima Repubblica
di Venezia dal Golfo di Trieste alle Bocche di Cattaro; quell’identità che
venne brutalmente offesa dal regime nazionalcomunista titino, e che oggi
vogliamo portare a nuovo splendore.
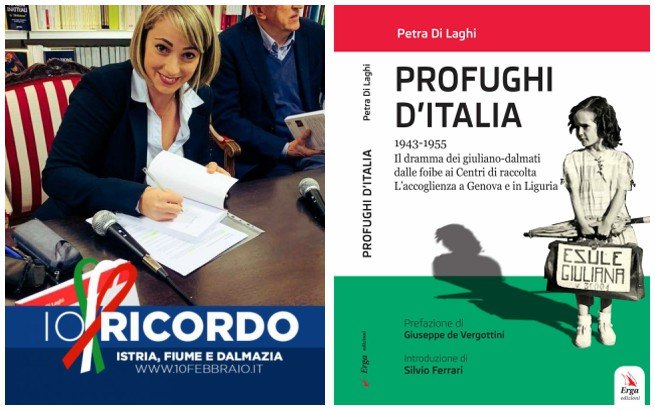
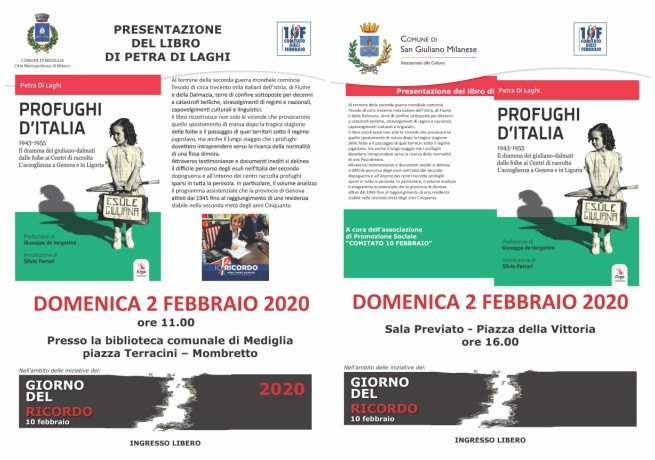
 Newsletter
Newsletter  Pubblicità
Pubblicità  Redazione
Redazione