Il cuore nero di Milano: la vera storia del mostro della Stretta Bagnera
Intrighi, segreti ed omicidi a Milano: le indagini che portarono alla scoperta dei crimini di Antonio Boggia (Nato il 23 dicembre 1799), il serial killer che terrorizzò la città nel XIX secolo

20 marzo 2025
Un rigido inverno avvolgeva le sponde del Lago di Como quando, il 23 dicembre 1799, in un’umile casa di Urio, nacque Antonio Boggia, l’uomo che sarebbe diventato uno dei primi serial killer italiani dell’epoca moderna.
Crescendo, Antonio si rivelò un giovane taciturno, dall’indole sfuggente. A 19 anni, nel 1818, lasciò il paese natale con la speranza di costruirsi un futuro a Milano, la grande città che attirava sognatori e disperati. Ma i suoi sogni si infransero presto: il lavoro scarseggiava e la sua personalità ambigua lo portò più alla disonestà che al sacrificio. Incapace di mantenere un impiego stabile, lasciò Milano per il Piemonte, dopo aver accumulato debiti ed essersi lasciato alle spalle fornitori truffati e tasse non pagate.
Dopo anni, Antonio fece ritorno a Milano, una città dove chi un tempo lo aveva conosciuto, probabilmente lo aveva dimenticato. Era l’occasione perfetta per ricominciare nell’ombra. Si stabilì prima in via Montenapoleone, e successivamente al civico 2 di via Nerino. Schivo ma scaltro, si adattava a qualsiasi mestiere pur di sopravvivere: lavorava come muratore, carpentiere e, per un certo periodo, persino come fochista a Palazzo Cusani, all’epoca sede del comando militare austriaco. Quando fece ritorno a Milano, la sua vita era già stata segnata da un evento traumatico: la misteriosa perdita della moglie, che lo aveva lasciato solo con almeno un figlio a carico. Quel dolore, invece di abbatterlo, sembrò renderlo ancora più duro e solitario, spingendolo sempre più ai margini della società. Boggia era anche un frequentatore abituale delle aste, dove acquistava e rivendeva oggetti con sorprendente disinvoltura.
Nessuno lo sospettava ancora, ma nel buio dei vicoli di Milano stava per nascere un mostro.

Immagine generata con AI
Il lato oscuro di Boggia: un tentato omicidio che cambiò tutto
Dietro la facciata di uomo schivo, ma cordiale, timorato di Dio e assiduo frequentatore della vicina parrocchia di San Giorgio al Palazzo, si celava un'indole ben più oscura. Antonio Boggia viveva un'esistenza silenziosa, quasi invisibile, fatta di lavori saltuari e senza alcuna frequentazione particolare. Ma un giorno, il suo nome emerse in un episodio tanto inquietante quanto scioccante, che avrebbe cambiato per sempre la percezione che la città aveva di lui.
La mattina del 3 aprile 1851, Antonio Boggia attirò con un inganno il signor Comi, un anziano contabile, nel suo magazzino in stretta Bagnera (oggi via Bagnera), con la scusa di dovergli mostrare alcuni conti da revisionare. Il luogo, buio e silenzioso, era perfetto per il suo piano. Quando Comi si chinò sui documenti, Boggia, con un gesto improvviso e violento, lo colpì alla testa con una scure, tramortendolo. Il colpo fu violento, ma fortunatamente non letale. L'anziano contabile, sanguinante e confuso, riuscì a riprendersi e, con le poche forze che gli restavano, fuggì dal magazzino. Mentre correva per le strade, inseguito da Boggia, incontrò un conoscente, una guardia imperiale della finanza, che, sconvolto dalla sua condizione, gli prestò immediatamente soccorso. Il militare lanciò l’allarme e fece arrestare Boggia, ponendo fine al suo tentativo di omicidio.
Colto sul fatto, l’uomo, con grande astuzia, riuscì a farsi passare per malato di mente. La sua difesa fu così convincente che la richiesta venne prontamente accolta. Nonostante il crimine gravissimo, fu dichiarato incapace di intendere e di volere e, anziché finire in prigione, venne condannato a trascorrere un periodo in manicomio. Fu rinchiuso nella Senavra, un istituto psichiatrico che da prima residenza e poi convento, era stato trasformato in manicomio per volere di Maria Teresa d'Austria. Dopo alcuni anni e una serie di trattamenti medici, nonostante la sua natura oscura e manipolatrice, Boggia venne dichiarato "guarito" ed incredibilmente rimesso in libertà.
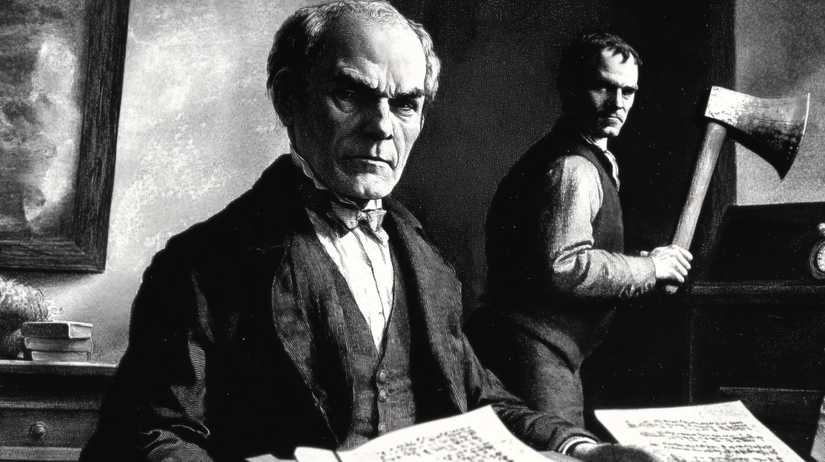
Immagine generata con AI
La scomparsa della vedova Perrocchio
Il 26 febbraio 1860, il signor Giovanni Maurier si presentò negli uffici del Tribunale civile e criminale provinciale di Milano in Corso San Gottardo per denunciare la scomparsa della madre, Ester Maria Perrocchio, un’anziana vedova ultrasettantenne. La donna abitava al secondo piano di un caseggiato di sua proprietà, situato in via Santa Marta al numero 10 (2824 secondo la numerazione teresiana).
Maurier, pittore decoratore presso la Richard ceramiche e residente in un sobborgo vicino alla parrocchia di San Cristoforo al Naviglio, raccontò di essersi recato a casa della madre qualche tempo prima per farle visita. Non trovandola né nell’abitazione né nella vicina chiesa di San Giorgio al Palazzo, che era solita frequentare, si era rivolto ad una coppia di inquilini del palazzo, i coniugi Trasselli. Da loro apprese che la donna era partita alcune settimane prima, dicendo di voler andare sul lago di Como.
In un primo momento, il figlio non si preoccupò più di tanto: conosceva bene le eccentricità della madre ed, inoltre, i loro rapporti non erano mai stati particolarmente affettuosi. Ma quando anche la settimana successiva tornò a casa della madre senza trovarla, iniziò ad avere molti sospetti. Deciso ad ottenere risposte, pressò i coniugi Trasselli con domande sempre più insistenti.

Immagine generata con AI
Fu allora che emerse il nome di Antonio Boggia, un capomastro che abitava in via Nerino. Secondo gli inquilini, l’uomo era diventato molto intimo con la signora Perrocchio dopo aver eseguito alcuni lavori di muratura nel palazzo.
Dopo la misteriosa scomparsa della donna, Boggia si era comportato come se il palazzo fosse ormai di sua esclusiva proprietà. Aveva arbitrariamente aumentato gli affitti, avviato lavori di ristrutturazione senza consultare nessuno e, fatto ancora più inquietante, aveva fatto sparire tutti i gatti dal cortile. Quelle creature erano state la compagnia più cara della vedova, che le nutriva e curava ogni giorno con affetto quasi materno. Il loro improvviso allontanamento lasciò gli inquilini perplessi, ma nessuno osava sfidare l’uomo che sembrava ormai detenere un’autorità assoluta sullo stabile.
Preoccupato da questa situazione, il signor Maurier decise di vederci chiaro e rintracciò Boggia per ottenere spiegazioni. L’uomo, con fare disinvolto, gli raccontò che sua madre si trovava in vacanza sul lago di Como e che, durante la sua assenza, gli aveva affidato la gestione del palazzo. A riprova delle sue parole, estrasse alcune lettere apparentemente scritte dalla Perrocchio, in cui la donna gli impartiva istruzioni precise sulla conduzione dello stabile. Tuttavia, a Maurier quelle missive sembrarono troppo generiche, quasi impersonali, ma non ebbe modo di insistere oltre.
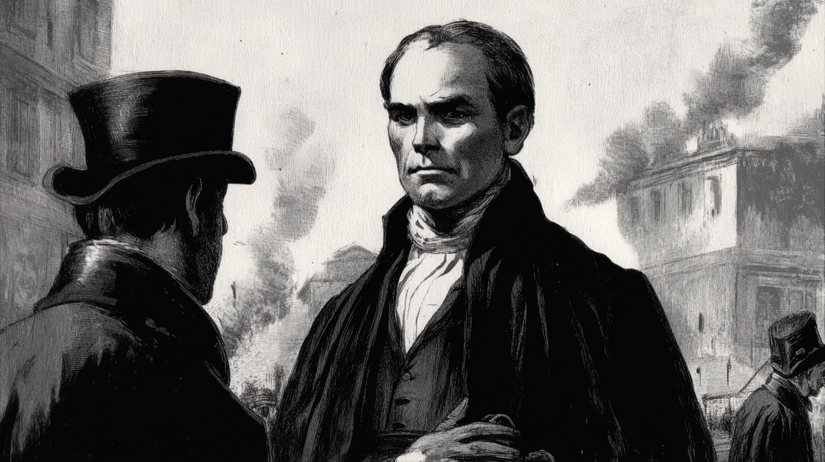
Immagine generata con AI
Qualche tempo dopo, Boggia si presentò alla porta di Maurier accompagnato da un uomo robusto e dall’aria sbrigativa. Con tono conciliante, gli fece una proposta allettante: sua madre aveva deciso di affittare l’intero edificio ad un solo inquilino per un lungo periodo, garantendosi così una rendita stabile. In cambio della sua collaborazione, Maurier avrebbe ottenuto l’appartamento al secondo piano in comodato d’uso, senza dover versare alcun canone. Non solo: se avesse accettato, Boggia lo avrebbe accompagnato personalmente dal notaio per redigere l’atto e ricevere in anticipo l’intera somma dell’affitto annuale del primo anno, che la madre avrebbe lasciato al figlio. Quest’ultimo, credendo che la madre fosse rinsavita e stesse cercando una conciliazione con lui, decise di accettare. L’offerta era senza dubbio allettante e, in parte, Maurier si sentiva rassicurato. Tuttavia, l’insistenza di Boggia continuava a lasciargli un’inquietudine sottile, impedendogli di fidarsi del tutto.
Decise quindi di seguire Boggia dal notaio Cattaneo, dove lo attendeva però una rivelazione sconcertante. Appena sentì il nome della signora Perrocchio, il notaio aggrottò la fronte e scosse la testa. Con voce ferma, rivelò a Maurier di aver già avuto a che fare con la vedova mesi prima, quando si era presentata nel suo studio accompagnata proprio da Boggia. Quel giorno, l’uomo voleva farle firmare una procura che gli concedeva pieni poteri sulla gestione del palazzo e su tutti i beni della donna. Tuttavia, qualcosa non aveva convinto il notaio. La signora Perrocchio appariva confusa, smarrita, come se non fosse del tutto consapevole delle implicazioni del documento. Insospettito, Cattaneo si era rifiutato di autenticare la procura, temendo che la vedova fosse vittima di circonvenzione d’incapace. Anzi, preoccupato per la sua incolumità, aveva segnalato il caso alla pretura mandamentale, chiedendo ufficialmente che venisse aperto un procedimento di interdizione.
La pratica però era stata archiviata, perchè Boggia, con astuzia, aveva dichiarato che la donna si era trasferita a Como, sottraendosi così alla giurisdizione della procura di Milano. In questo modo, l’intervento delle autorità si era arenato, lasciando Boggia libero di agire senza ostacoli.
Maurier uscì dallo studio del notaio con un senso di inquietudine crescente. Dov’era davvero la madre? Perché nessuno l’aveva più vista?

Immagine generata con AI
Dalla scomparsa alla confessione: il destino atroce della vedova Perrocchio
Il giudice Crivelli, incaricato delle indagini, comprese immediatamente la gravità della situazione. Tutti gli indizi conducevano ad Antonio Boggia, l’uomo che dopo la scomparsa della signora Perrocchio, si era comportato come il padrone incontrastato del palazzo. Crivelli iniziò ad interrogare gli inquilini dello stabile, cercando ogni minimo dettaglio che potesse fare luce sul mistero. Fu così che emerse una testimonianza inquietante. Il portinaio raccontò che il giorno in cui la vedova fu vista per l’ultima volta, Boggia era impegnato in alcuni lavori di manutenzione al tetto. Quel giorno, aveva chiesto due secchi d’acqua, ordinando che gli fossero portati proprio nell’appartamento della donna. Poche ore dopo, qualcuno lo aveva visto scendere le scale con un pesante cesto sulle spalle. Da quel momento, nessuno vide più la signora Perrocchio.
Di fronte a queste rivelazioni, il giudice ordinò una perquisizione accurata dell’edificio che portò ad una scoperta agghiacciante: nascosto in un’intercapedine, murato con cura tra le pareti del palazzo, giaceva il corpo della vedova Perrocchio. Tuttavia, mancavano la testa e le gambe, probabilmente trasportate altrove nel misterioso cesto. Il cadavere era ormai in avanzato stato di decomposizione, segno che il delitto risaliva a diverse settimane prima.
Quando Boggia fu condotto sul luogo del ritrovamento, non poté più negare l’evidenza. Riconobbe il corpo della Perrocchio e, senza mostrare alcuna emozione, confessò l’omicidio. Raccontò di averla colpita con una scure nel suo appartamento e di aver utilizzato l’acqua per ripulire ogni traccia di sangue. Dopo aver rovistato tra gli effetti personali della vittima alla ricerca di denaro e gioielli, vendette gli oggetti di valore a un negoziante della zona, cercando di cancellare ogni prova del suo crimine.
Ma la sua messinscena era crollata. Il giudice Crivelli aveva ormai svelato l’orrore che si celava dietro la scomparsa dell’anziana signora.

Immagine generata con AI
Un orrore senza fine: il ritrovamento di altri tre corpi
Proseguendo nelle indagini, gli inquirenti fecero una scoperta ancora più inquietante: Antonio Boggia possedeva altre due procure speciali notarili, rilasciate da Angelo Serafino Ribone e dal ferramenta Giuseppe Meazza, entrambi scomparsi nel nulla da tempo. La svolta nelle indagini arrivò quando gli investigatori decisero di perquisire la cantina di Boggia, situata nella piccola Stretta Bagnera (oggi via Bagnera). Quella cantina, che l’uomo utilizzava come deposito per gli attrezzi, nascondeva una realtà agghiacciante. Tra le mura polverose e i vecchi strumenti abbandonati giacevano tre cadaveri, rimasti sepolti nel silenzio e nell'oscurità per anni. Il luogo scelto da Boggia per occultare i suoi crimini era un piccolo locale remoto, lontano dallo sguardo di curiosi e passanti, accessibile solo attraverso una scala interna che portava direttamente alla stanza. Il luogo perfetto per mettere in atto i suoi delitti.

Immagine generata con AI
Il primo corpo rinvenuto nella cantina di Boggia fu identificato come quello di Angelo Serafino Ribone, un manovale scomparso da anni. Gli inquirenti scoprirono il suo nome grazie ad una procura del 1848, ritrovata nel magazzino dell’assassino. Il documento rivelava che Ribone aveva incaricato Boggia, un tempo suo datore di lavoro, di riscuotere 1.400 svanziche depositate presso una sua parente sul lago di Como. Ma non era l’unica procura. La prima, generale, rogata dal notaio Gaslini di Milano, non era stata ritenuta valida dalla cugina di Ribone, che si era rifiutata di consegnare il denaro. Solo con un secondo mandato, speciale, redatto dal notaio Terzaghi di Lodi, la donna aveva accettato di affidargli la somma, convinta dalle rassicurazioni di Boggia. L’uomo le aveva raccontato che quei soldi servivano a Ribone per sposarsi a Lodi. In realtà, Ribone non aveva mai firmato alcuna procura. Probabilmente, si era ingenuamente confidato con Boggia riguardo alla sua piccola fortuna, senza immaginare che il muratore avesse già deciso di tradirlo. Attirato con un pretesto nella cantina di via Bagnera, il manovale fu brutalmente ucciso a colpi di scure. Il suo corpo, come quello delle altre vittime, venne occultato tra le fondamenta dello scantinato. Dopo l’omicidio, Boggia si recò dai due notai con un complice conosciuto in osteria che si spacciò per Ribone, e si fece redigere gli atti di mandato per riscuotere il denaro. Al secondo tentativo riuscì quindi ad impossessarsi della somma, cancellando poi ogni traccia del povero Ribone.

Immagine generata con AI
Unendo vecchie denunce e testimonianze, gli inquirenti riuscirono ad identificare il secondo corpo ritrovato nella cantina di Boggia. Scoprirono che, nei giorni precedenti la sua misteriosa scomparsa, un commerciante, di cui non si avevano notizie da tempo, era stato visto parlare a lungo in modo facinoroso con Boggia riguardo a qualche affare. Quest’uomo, presto si rivelò essere un certo Giuseppe Marchesotti, negoziante e mediatore di granaglie. In questo caso Boggia non ebbe bisogno di complici o notai. Approfittando della sua presenza alle aste pubbliche, l'uomo individuò Marchesotti, un esperto del settore, e si avvicinò a lui con l'inganno. Lo convinse ad investire in un affare che richiedeva un capitale iniziale di 4.000 svanziche, una cifra che il mediatore accettò di investire, fidandosi delle promesse di guadagni facili. L'ultima volta che Marchesotti fu visto fu sabato 15 gennaio 1850. Uscì di casa di buon'ora, con i soldi che gli erano stati prestati da un conoscente il giorno prima, per concludere l'affare. L'uomo fu visto nell'osteria del paese, in compagnia di Boggia, e poco dopo i due si allontanarono insieme. Da quel momento, Marchesotti scomparve nel nulla. Nei giorni seguenti, la madre anziana di Marchesotti e il signor Castiglioni, che gli aveva prestato il denaro, sporsero denuncia di scomparsa. Nonostante la preoccupazione, il caso fu archiviato senza troppe indagini, con l'ipotesi che Marchesotti fosse fuggito con il denaro. La verità, però, era ben diversa: Boggia aveva, ancora una volta, architettato un omicidio per impadronirsi di un'ingente somma. E così, anche Marchesotti divenne una delle sue ignare vittime.

Immagine generata con AI
Durante gli scavi, emersero alcuni effetti personali appartenuti alle vittime. Tra questi, un oggetto insolito rivelò definitivamente l’identità del terzo corpo ritrovato: un cinto per l’ernia, riconosciuto come appartenente a Giuseppe Meazza. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, venne identificato con certezza anche grazie ad un dettaglio inconfondibile: gli mancavano gli incisivi, proprio come l’uomo scomparso anni prima. Meazza era un ferramenta proprietario di una bottega in zona Carrobbio, ed aveva incontrato Antonio Boggia grazie ad un amico comune, il signor Binda, noto per la sua solida reputazione. Non passò molto tempo prima che Boggia riuscisse ad ottenere un mandato per amministrare la bottega di Meazza, che all'epoca attraversava un periodo di difficoltà economiche. Con astuzia e promesse di guadagni facili, Boggia ingannò Meazza, convincendolo a firmare una procura per permettergli di gestire l'attività. Nel corso dei mesi successivi, Boggia prese il controllo della bottega, si occupò della gestione e pagò anche i dipendenti, facendo credere che stesse risollevando le sorti dell’attività. Ma ben presto l'inganno si fece evidente. Boggia, sfruttando il mandato che gli era stato conferito, riuscì a vendere la bottega a Binda ad un prezzo ben inferiore al valore reale del negozio. Il risultato fu che Meazza, che si fidava dell’uomo, non solo non ricevette mai il denaro dovuto per la sua attività, ma nell’aprile del 1850 sparì nel nulla, come se fosse stato inghiottito dalla terra. Le indagini portarono alla luce un atto di vendita firmato da Boggia in qualità di rappresentante di Meazza, e una denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia del ferramenta. Inoltre, emerse che un commerciante, che aveva acquistato successivamente la bottega da Binda, aveva sporto denuncia per truffa, pare in merito ad una serie di forniture di merce comprese nel prezzo d’acquisto ma mai consegnate. Nonostante tutte queste prove, al tempo le indagini non portarono a nulla, e il caso venne archiviato con l’ipotesi che Meazza fosse fuggito con i soldi. Ma quando il corpo dell’uomo venne rinvenuto nella cantina di Boggia, la verità emerse in tutta la sua crudeltà: il ferramenta era stato attirato lì da Boggia, probabilmente con la scusa di parlare della situazione economica della sua attività e una volta nella cantina, brutalmente ucciso, come gli altri.
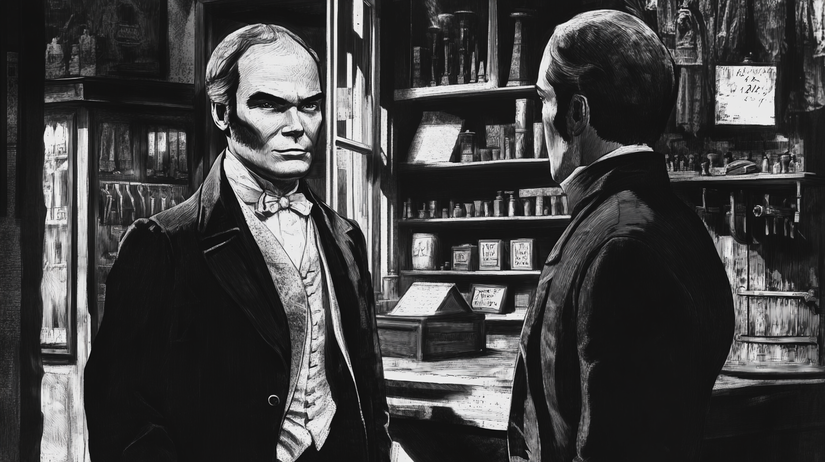
Immagine generata con AI
Il processo e la condanna a morte
Il processo contro Antonio Boggia cominciò il 18 novembre 1861 e durò cinque giorni. La difesa tentò di ottenere l'infermità mentale, basandosi anche sulla precedente assoluzione per infermità mentale per il tentato omicidio del contabile Comi. I suoi compagni di cella raccontarono di come camminasse nudo, cantasse di notte in preda a crisi di pazzia e accusasse sempre forti mal di testa. La difesa sosteneva che se Boggia aveva agito, lo aveva fatto perché glielo aveva ordinato "la testa". Ma le prove schiaccianti confermarono la premeditazione e l'intento di truffa, rapina e omicidi. Boggia venne condannato per l’omicidio a scopo di rapina di Angelo Serafino Ribone (avvenuto nell'aprile 1849), di Giuseppe Marchesotti (avvenuto il 15 gennaio 1850) e di Pietro Meazza (avvenuto nell'aprile del 1850), per il tentato omicidio di Comi (avvenuto il 2 aprile 1851) e per l'omicidio a scopo di rapina della vedova Perrocchio (avvenuto l'11 maggio 1859). A questi reati si aggiunsero le tentate truffe e le sostituzioni di persone in atti pubblici.
La condanna a morte di Antonio Boggia fu emessa senza possibilità di appello. Inutili si rivelarono i ricorsi in seconda e terza istanza, così come la richiesta di grazia inviata al re. Il 6 aprile 1862, mentre era rinchiuso in carcere, Boggia apprese che gli restavano ormai poche ore di vita. L’esecuzione, destinata a passare alla storia, sarebbe stata l’ultima condanna a morte di un civile eseguita a Milano fino alla Seconda Guerra Mondiale. Per portarla a termine furono chiamati due boia, uno da Parma e l’altro da Torino. Eppure, non erano mancati volontari tra i cittadini inferociti e desiderosi di giustizia, ma tutte le candidature spontanee furono respinte. L’8 aprile 1862, il condannato venne fatto salire su un carro coperto da un telo nero e condotto lentamente verso il patibolo, allestito tra Porta Ludovica e Porta Vigentina. La città intera sembrava trattenere il fiato, mentre una folla immensa si accalcava lungo il tragitto, mossa da un misto di curiosità, sete di vendetta e morboso fascino per l’evento. Uomini, donne e persino bambini si accalcarono per assistere all’ultimo atto della vita del primo serial killer della Milano moderna. Giunto sul luogo dell’esecuzione, il corteo si fermò. Boggia venne fatto scendere e condotto al patibolo, dove, di fronte alla moltitudine silenziosa e tesa, fu impiccato. Ma l’orrore non era ancora finito. Una volta accertato il decesso, il corpo venne adagiato e la sua testa decapitata. Il macabro trofeo fu poi spedito al gabinetto anatomico dell’Ospedale Maggiore, dove fu trattato per la conservazione ed esaminato da illustri studiosi, tra cui il celebre criminologo Cesare Lombroso. Quest’ultimo analizzò i tratti somatici di Boggia, confermando la sua teoria sulla fisionomia criminale: il volto dell’assassino, a suo dire, presentava caratteristiche tipiche del delinquente nato.
Per quasi un secolo, la testa di Boggia rimase conservata all’Ospedale Maggiore, fino a quando, nel 1949, venne finalmente inumata nel cimitero di Musocco. Il resto del corpo, invece, era già stato sepolto nel cimitero del Gentilino, fuori Porta Ludovica, un luogo oggi scomparso, le cui salme furono in seguito trasferite al Cimitero Monumentale o al Maggiore.

Immagine generata con AI
Un’ombra eterna su via Bagnera
Così si concluse la storia di Antonio Boggia, il "Mostro della Stretta Bagnera", il primo assassino seriale della Milano moderna. Nonostante il passare degli anni, il suo nome e i suoi crimini non furono mai dimenticati, rimanendo impressi nella memoria della città. Ancora oggi, si racconta che chi passeggia per la stretta via Bagnera possa avvertire un improvviso soffio di vento gelido: secondo la leggenda, sarebbe lo spirito inquieto dell’uomo, che continua a vagare tra quei vicoli.
Il nome di Boggia entrò anche nel linguaggio popolare milanese, dove divenne sinonimo di ipocrisia e inganno mascherati da buone maniere. Per anni, si usò l’espressione “non fare il Boggia” per descrivere chi, con fare affabile e rassicurante, voleva conquistare la fiducia altrui solo per tradirla. Esattamente come faceva lui con le sue vittime.
Stefano Brigati
Stefano Brigati

Immagine generata con AI
20 marzo 2025
 Newsletter
Newsletter  Pubblicità
Pubblicità  Redazione
Redazione 



























